LA RESPONSABILITÀ SANITARIA DOPO COVID-19
Senza un rinnovato patto tra medico e paziente il rischio di un’esplosione di contenziosi, dopo lo spegnersi della fase peggiore della pandemia, è molto alto. Eppure, proprio l’emergenza che tutti abbiamo vissuto suggerirebbe un maggiore rispetto verso chi rischia ogni giorno la propria vita per curare anche chi non potrà guarire

15/05/2020
👤Autore:
Maurizio Hazan, giurista e managing partner dello studio legale Taurini-Hazan
Review numero: 74
Pagina: 34
La drammatica emergenza che stiamo vivendo ci induce a guardare alla sanità, e agli operatori che la sostengono, con occhi necessariamente diversi: Covid-19 può divenire l’emblema di una rinnovata consapevolezza, dove la logica del crucifige, dell’obbligazione di risultato e del diritto alla guarigione, non può condurci lontano. La fragilità messa a nudo dal virus ci dice che, come la legge 24/2017 ha insegnato, è la prevenzione a dover essere principio fondante e autentico fuoco prospettico attorno al quale rimodulare anche i criteri cardine della responsabilità. Tanto più in un contesto privo di coordinate certe, in cui a distanza di più di qualche mese dallo scatenarsi della crisi, il più grande sforzo rimane quello di dover lavorare sull’alea, per trasformarla in esperienza utile, prima, e poi in regola. Il tutto con la complicazione indotta da un’emergenza che anticipa i tempi di gioco, obbligando a rincorrere ciò che non si riesce del tutto a capire, e dunque a prevenire.
IL RISPETTO DOVUTO
La gravità di questi ultimi eventi ci ricorda dunque, con una durezza che non avremmo voluto conoscere, che la chimerica prospettiva di un sicuro dominio delle situazioni, e la correlata aspettativa di guarigione, non sono un dogma né un diritto acquisito. E ci costringe a pensare che chi esercita la sacra professione di cura deve, ora più che mai, meritare il rispetto del suo impegno a prendere in carico, a suo stesso rischio, le situazioni più difficili. Quelle che sarebbe ben più comodo evitare, se non si fosse animati dall’etico impegno di una professione che si intinge nella vocazione che la precede. E ciò a maggior ragione laddove gli esercenti le professioni sanitarie assumono, per così dire, il ruolo di parti di unità complessa, come soggetti eterodiretti la cui azione annega, si completa, si colora e si struttura nella sinergia e nell’intreccio di un facere collettivo e di una responsabilità condivisa.
Ciò a cui, chi scrive, non vorrebbe assistere, in questi momenti di drammatica crisi, è la possibile ripresa di scenari accusatori, o la caccia ai responsabili tra coloro i quali (medici, altri professionisti della sanità o organizzazioni complesse) sono stati ridotti allo stremo pur di provare ad arginare un fenomeno di portata epocale, che resterà gravemente inciso nella pagine del futuro racconto della storia moderna.
NON RENDERE DIFFICILI ANCHE LE COSE FACILI
Occorre dunque evitare che la battaglia al Covid-19 sia intralciata da percorsi risarcitori nella maggior parte dei casi inopportuni, se non disdicevoli, quando speculativi. È il concetto stesso di emergenza, mai come adesso invocabile, a segnare la differenza rendendo spesso difficili anche le cose facili, ponendo in perfetta connessione il concetto di colpa grave e l’urgenza terapeutica e rimarcando l’esigenza di cogliere le contingenze nelle quali vi è una particolare difficoltà della diagnosi e della cura, sovente accresciuta dall’urgenza (si veda sul punto l’illuminata motivazione della sentenza di Cassazione 24528 del 10 giugno 2014). E in quest’ottica merita di ritrovar linfa la regola espressa dall’articolo 2236 del Codice civile, che incentiva la presa in carico dei casi e delle situazioni più gravi e rischiose, limitando la responsabilità professionale alle sole ipotesi di colpa grave, ogni qualvolta ci si trovi innanzi a serie difficoltà operative (difficoltà davvero straordinarie, nel caso del Covid-19).
Del resto la misura dell’impegno professionale è già fin troppo colma, oggi, nell’affannosa ricerca di coordinate o rimedi ancora empirici, a fronte di un mostro virale la cui attitudine patogena non è stata ancora ben compresa, prima ancora che dominata, dalla scienza.
UN RISCHIO NON ELIMINABILE
E se ciò vale per tutto quel che attiene ai problemi correlati alle difficoltà di diagnosi, di effettiva intercettazione dei casi patologici e di cura, altre riflessioni meritano di esser svolte di fronte alla probabile esplosione di richieste risarcitorie relative a contagi (asseritamente) contratti proprio all’interno dell’ospedale.
Ragionando in termini generali può essere opportuno ricordare come, di per loro, le infezioni nosocomiali rappresentino un fenomeno sì controllabile e prevenibile ma non completamente eliminabile; il rischio di un contagio all’interno degli ambienti di cura può essere ridimensionato attraverso una serie di misure, ma non è ontologicamente azzerabile. Esiste insomma un’alea che è irriducibile, al di là dello sforzo diligente esigibile. E ciò vale a maggior ragione nel caso del Covid-19, la cui virulenza e aggressività ha messo in crisi, in tutto il mondo e a diversi livelli, le capacità di risposta delle organizzazioni sanitarie complesse, incapaci di allestire nel brevissimo tempo in cui sono state travolte dal fenomeno misure organizzative utili a impedire che l’infezione, pur tipicamente esogena, si diffondesse all’interno degli ospedali.
UNA CARENZA STRUTTURALE DI RISORSE
Nella cruda realtà in cui gli stessi medici e gli altri operatori contraggono l’infezione con disarmante facilità, gli strumenti di prevenzione normalmente in uso dimostrano di non esser sufficienti, specie in situazioni di emergenza come quella attuale, in cui tra l’altro continua a sapersi ben poco di questa malattia. E nel panico pandemico dei primi giorni, i protocolli emergenziali sono mutati di giorno in giorno, traendo insegnamento dalla loro inadeguatezza, a sua volta rivelata dall’esplosione dei contagi ed enfatizzata da una carenza strutturale delle risorse, personali e strumentali, disponibili. Il controllo del singolo gesto altrui, in questi contesti, risultava forse chimerico e forse neppure richiedibile a chi, con risorse limitate, si è trovato addirittura a dover fare i conti con la selezione dei pazienti, per capire chi poter direttamente accogliere e curare, e chi no.
LA VIA DELLA SOLIDARIETÀ
Certo, qualcosa può non aver funzionato. Da tempo l’allarme era stato lanciato, almeno in determinati ambienti. E col senno di poi è facile dire che si sarebbe potuto/dovuto fare meglio: ma guardando con onestà ai limiti connaturati al nostro agire collettivo, individuale, pubblico e privato, non può non prendersi atto di quanto questa pandemia abbia stravolto l’intero globo terraqueo, mettendo in ginocchio anche sistemi stranieri che, in luogo di prenderci ad esempio, ci additavano come untori e si dichiaravano pronti a reggere, meglio di noi, l’urto del nuovo coronavirus. Questo non significa voler essere fatalisti né tantomeno immaginare un sistema che, a fronte della gravità del momento, debba vivere di una propria immunità giuridica, e andare sempre e comunque esente da censure. Non sia mai.
Rimane il fatto che i plausibili scenari di crisi economica che ci attendono, unitamente alla numerosità delle vittime, potrebbero favorire un’esplosione di contenziosi, prontamente alimentati da una certa industria del sinistro. Ciò non deve stupire: la responsabilità civile, ove letta in chiave non preventiva ma patologica (e non come missione ma come rimedio), è sovente piegata alla realizzazione di scopi trasversali di ingegneria sociale, mirata alla sistematica ricerca di soggetti sui quali far ricadere il peso economico di danni socialmente diffusi e rilevanti.
Ma a parere di chi scrive il sostegno sociale che si va cercando non può essere trovato (solo) nella via dei risarcimenti e dei contenziosi, ma soprattutto in quella della solidarietà.
UN FONDO OLTRE ALL’ASSICURATORE SOCIALE
È proprio sul versante della solidarietà che potranno pensarsi a nuove tutele, scevre da intenti accusatori o, peggio, intimidatori: così potrà pensarsi a un Fondo che, lasciando intatte le responsabilità più gravi, possa garantire, in aggiunta all’assicuratore sociale, i diritti degli operatori sanitari rimasti sul campo o comunque colpiti dal virus. Ed è comunque solo attraverso altri sistemi d’indennizzo che, a conti fatti e uscendo dalla crisi, si potrà forse prendere in considerazione l’idea, tutt’altro che facile, di fornire un sostegno alle altre vittime del Covid-19 che non abbiano titolo per una qualificata seria e fondata azione di responsabilità.
È comunque nell’immediato che occorre farsi trovar pronti. Le vigenti regole del diritto, interpretate eticamente e plasticamente alla luce degli attuali scenari di crisi, potrebbero esser bastevoli per respingere attacchi contenziosi disinvolti. Ma la prospettiva di superare indenni eventuali contenziosi giudiziali non è di per sé consolatoria: il solo fatto di doversi difendere in giudizio rappresenta una sconfitta per chi, in questi transiti storici, dovrebbe occuparsi di tutt’altro. Occorre dunque altro, e un barrage più incisivo.
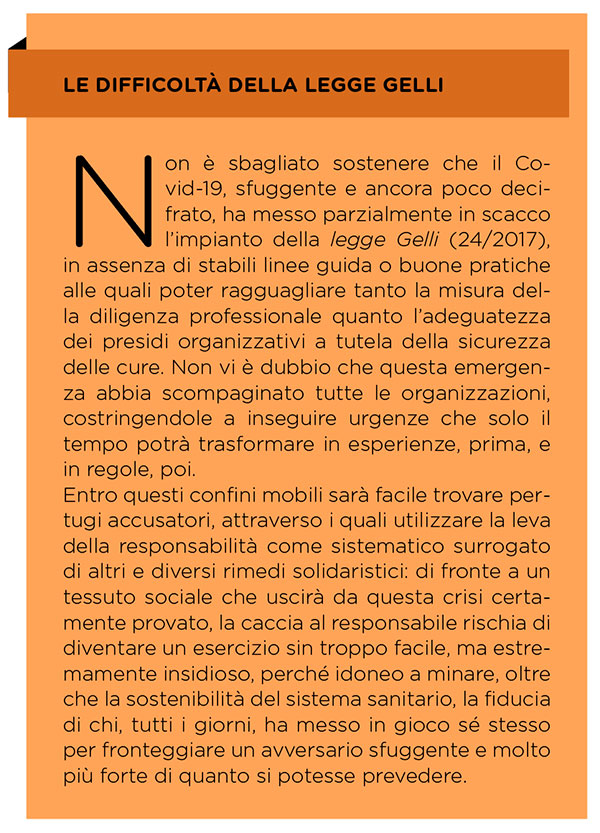
NON SERVE UNO SCUDO, SERVONO REGOLE
Si è sentito, a tal proposito, sovente parlare di una normativa emergenziale volta a scudare le responsabilità, dei professionisti e delle strutture, di fronte alla possibile pioggia di richieste risarcitorie che la presente crisi probabilmente scatenerà.
A parere di chi scrive parlare di scudo è però esercizio improvvido, semanticamente e letteralmente. Non è di uno scudo quello di cui si ha bisogno. Ma di regole: di regole calzanti e adeguate allo stato attuale di un’emergenza che, lo abbiamo detto più volte, rende difficile e complesso anche quel che è facile e che abbatte le normali capacità di risposta anche per patologie diverse dal Covid-19, a fronte dello scompaginamento delle tradizionali modalità e priorità di intervento.
Regole, dunque. E non scudi. L’ipotesi, da taluno ventilata, di una limitazione delle responsabilità civili al solo caso di dolo rischiano di stare e cadere con le loro premesse, non essendo francamente immaginabile che le gravi colpe rimangano impunite.
UN’OCCASIONE PER RIDEFINIRE LA COLPA GRAVE
Il problema sta semmai nell’esigenza di fare uscire il concetto di colpa grave dalle coltri di una discrezionalità giurisprudenziale che talvolta potrebbe rischiare di trasmodare in arbitrio. E che oggi più che mai dovremmo evitare, accogliendo con favore la possibilità di finalmente circostanziarla, nei limiti del possibile, quella colpa grave, che costituisce del resto misura e paradigma di quel che proprio, neppure in emergenza “non si può fare”, se non pagandone le conseguenze. In assenza di regole di responsabilità più chiare, il rischio dell’aumento di una già serrata conflittualità giudiziale potrebbe frantumare, anziché ripopolare, quel mercato assicurativo su cui la legge Gelli faceva affidamento per contribuire a sostenere, con la forza di una tasca capiente (obbligatoria), i delicati equilibri del nostro sistema sanitario. La protezione del nostro sistema sanitario, complessivamente considerato, rimane comunque lo scopo prioritario al quale dover tendere, nell’interesse primo dei pazienti.
È solo mantenendo nervi saldi, serenità di approccio e comunanza di intenti che transiti drammatici come quelli che stiamo vivendo possono essere affrontati, contando sull’impegno di tutti gli operatori della sanità, che mai come ora siamo felici e riconoscenti di veder scendere in campo affrontando i drammatici rischi ai quali si espongono per il bene comune.
UN FRONTE GIÀ INFRANTO
Proprio per questo stupisce il fatto che, proprio nel corso della predisposizione di un progetto normativo emergenziale, il fronte degli interessi comuni si sia in realtà stranamente infranto, contrapponendo, anziché unire, le istanze di protezione delle strutture sanitarie, da un lato, e degli esercenti la professione sanitaria dall’altro. Quasi come se proteggere le strutture, sotto il profilo delle difficoltà organizzative e preventive certamente registrate nell’emergenza, equivalesse a sotterrare eventuali superiori responsabilità politiche, amministrative e di sistema, a danno dei professionisti. Come se i medici rivendicassero una posizione autonoma di difesa, quali corridori dell’ultimo miglio ed esposti, più di tutti, agli incerti di una situazione in qualche modo etero-determinata. Ci pare invece che entrambe le categorie soffrano e abbiano sofferto, e meritino di esser difese insieme, per consentir loro di continuare a garantire, insieme e anche per il futuro, la sostenibilità del sistema salute.
LA SFIDA PIÙ DURA
Perché contrapporsi, dunque? E perché contrapporre agli interessi del sistema sanitario quelli dei pazienti?
La prima garanzia per questi ultimi risiede nella tutela di un’alleanza terapeutica ancor più allargata rispetto al passato. Di quell’alleanza che il Covid-19 sembrava in un primo tempo esser riuscita a ricompattare, anche agli occhi dell’opinione pubblica. Di quell’alleanza che sostiene ogni impegno e allontana inutili difese, spingendo gli operatori della sanità a prendersi carico anche dei casi più difficili, anche a rischio della loro stessa salute.
Occorre miglior coesione e comunione di intenti. È il tempo dell’unione e non delle divisioni. E tantomeno della retorica. È il tempo di mettere in sicurezza il nostro sistema sanitario, sostenendolo nel suo insieme e sorreggendolo nella sfida più dura e dolorosa che la storia moderna, in tempo di pace, abbia mai conosciuto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
👥








